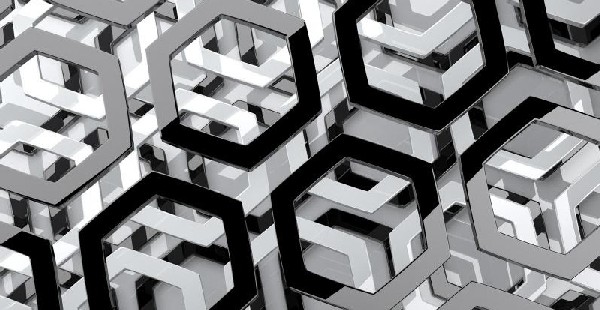Aikido: sistemi didattici e…l’opera al nero
Avevo diciotto anni e praticavo non male mezzofondo veloce in atletica leggera, nonostante non avessi un allenatore e le strutture sportive in penisola sorrentina, dove tutt’ora abito, fossero men che embrionali, alla fine degli anni sessanta. Da autodidatta, a sedici anni, mi battevo da pari a pari con un certo Alfonso Di Guida, in seguito più volte campione italiano e semifinalista sui 400 piani alle Olimpiadi di Montreal.
Fin da piccolo (timido e anche timoroso) ero affascinato dal karate e dalla malia del tameshiwari, forse pensando così di infrangere con le mie mani ogni opposizione, ma non c’erano palestre ne istruttori. Così quando lessi di una esibizione di aikido in Sant’Agnello, propedeutica all’inizio di corsi, andai per pura curiosità, rammaricato anzi che si trattasse di qualcos’altro e non del karate. Quello che vidi mi colpì, ma mi apparve subito complicato, anche troppo. Un particolare però mi indusse ad iscrivermi: ero reduce da una caduta in motocicletta e mi dissi che, almeno, avrei imparato a cadere.
Non avrei mai creduto che oggi, a “qualche anno” di distanza, avrei continuato, nella più imprevista serie di trasformazioni, una pratica a cui ritengo di essere stato fedelmente amoroso, anche forse più in quei momenti, in cui non mi si è visto sui tatami.
Quello che andava ad istituire il corso e sarebbe divenuto il mio sempai, all’epoca 1° dan, è a tutt’oggi esempio di coerenza con le proprie idee nonché testimone in prima persona, attraverso la sua splendida condizione psicofisica ad oltre settant’anni, dei salutevoli effetti di una benintesa pratica aikidoistica. Parlo di Pasquale Aiello, 6° dan e membro della Direzione Didattica dell’Aikikai d’Italia.
 Nell’ottobre 1972, a Praiano (SA), apparve un giapponese affascinante ed altero, per condurre una maratona di esami. Ebbi il mio 6° kyu, ma soprattutto il mio inconscio fu rapito dal carisma di un uomo, che ha finito per fungere negli anni critici, da immagine guida e catalizzatore di una già presente vocazione ad approfondirmi nel mondo interiore: parlo di Tada Hiroshi Shihan. Solo per questo, come si dice dalle mie parti, dovrei “fargli una statua”, per come ha dato il via e stimolato l’evoluzione strutturante del mio “essere nel mondo”.
Nell’ottobre 1972, a Praiano (SA), apparve un giapponese affascinante ed altero, per condurre una maratona di esami. Ebbi il mio 6° kyu, ma soprattutto il mio inconscio fu rapito dal carisma di un uomo, che ha finito per fungere negli anni critici, da immagine guida e catalizzatore di una già presente vocazione ad approfondirmi nel mondo interiore: parlo di Tada Hiroshi Shihan. Solo per questo, come si dice dalle mie parti, dovrei “fargli una statua”, per come ha dato il via e stimolato l’evoluzione strutturante del mio “essere nel mondo”.
E’ mia intenzione provare ad approfondire il significato specifico dell’aikido e credo che l’argomento -ambizioso- sarà oggetto di uno studio a parte. E’ innegabile però che ogni aspetto ed ogni sfaccettatura, sulla quale ci intratteniamo, in qualche modo riecheggi i significati e che le attuali riflessioni siano in qualche misura un prodromo di quel che verrà.
Quando cominciai a praticare l’aikido non se ne conosceva nemmeno il nome; più conosciuti erano il judo e il karate e quando qualcuno mi chiedeva cosa andavo a fare, frequentando raduni diretti da insegnanti “madrelingua”, io rispondevo: “L’apprendista stregone”.
Quei contenuti e la particolare atmosfera della pratica, difficilmente riproducibili a parole, riecheggiavano l’ambientazione di un laboratorio alchimistico e mal si prestavano a riferimenti tipo palestra sportiva. Ricordo nel vecchio dojo centrale di Roma, il mio primo raduno autunnale nel ’73, in cui si cominciava al mattino presto con l’anjodaza e si finiva la sera, contando non meno di 7 ore di pratica. Erano i tempi in cui il kinorenma non aveva ancora una sua sede specifica, distinta dalla pratica del tai jitsu.
Piano piano mi trovai avvinto dalla disciplina, proprio negli anni della mia formazione universitaria, e la laurea conseguita nel ’75 non mi rese così orgoglioso come lo shodan nel ’77. Nel frattempo pratica forense ed altre esperienze formative come la frequentazione dell’Istituto Diplomatico a Roma, con nove indimenticabili mesi di allenamenti al dojo centrale. I ritmi del keiko avevano un’intensità pazzesca (che non ho più ritrovato altrove) e il fiato non mi mancava solo grazie ai miei trascorsi podistici. Nel dojo praticavano tutti gli adepti della prima ora del maestro Tada e gli “scismi” erano ancora di là da venire.
Mi sentivo talmente privilegiato nel praticare un’arte che faceva diventare forti e profondi, che insegnava ad armonizzarsi anche col peggior nemico, da non capire poi come mai si verificassero disaccordi, che, al contrario, diventavano incomponibili fino a sfociare in una vera e propria diaspora.
Sul piano personale, affacciandomi alla vita lavorativa col cimentarmi nella libera professione del penalista, pativo lo stridente contrasto di affondare le mani nell’aspetto ombra dell’esistenza, con i solenni propositi e le nobili aspettative della mia pratica psicofisica.
Purtuttavia nutrivo la speranza che proprio nella complessità dell’aikido, si celasse la soluzione di quei problemi, anche se, successivamente ebbi a scoprire che a dispetto dei proclami di armonia, era diffusa tra gli eredi di Osensei una mania da primadonna e un corrosivo relazionarsi tra di loro. Questo stile è stato purtroppo assimilato dalle generazioni successive, come è in grado agevolmente di constatare oggi chi, superando il voltastomaco, si dia pena di scorrere le opinioni in libertà vomitate anonimamente sui vari blogs.
Come è possibile che un’arte affascinante, la cui densità di contenuti è palpabile anc he per il non adepto, produca questo tipo di risultati?
he per il non adepto, produca questo tipo di risultati?
Certamente è valida quella massima di esperienza sulle nefaste conseguenze della istituzionalizzazione di un contenuto interiore, di una verità esoterica che da un lato si vuole, con intento non criticabile, diffondere quasi messianicamente, dall’altro la diffusione diviene volgarizzazione e alienazione dal nocciolo contenuto.
Al di là delle petizioni di principio connesse all’aikido, una grossa fetta di praticanti e tra loro non pochi docenti, dissimula in superficiali coreografie, una debolezza interiore da cui non solo non ha cominciato ad emanciparsi, ma che paradossalmente è stata accresciuta da forme di inganno e/o autoinganno.
E’ questo un problema causato e circoscritto dai diversi punti di vista didattici, che si contendono la scena nel protezionismo delle diverse associazioni e che meglio andrebbe definito settarismo, o piuttosto il problema è di natura diversa e al cui riconoscimento fa velo proprio il settarismo?
Per formarmi questa opinione è dovuto trascorrere del tempo, tanto tempo, troppo tempo in cui le cose giacevano in una mistificante penombra. Ma forse è stato esattamente il tempo che ci è voluto.
Quando si vuole conoscere veramente un fenomeno ed in particolare un fenomeno complesso, non può esistere una selezione pregiudiziale sulle fonti di conoscenza. Se poi oggetto del conoscere è il soggetto conoscente, che deve necessariamente ri-conoscersi, per progettare poi come armonizzarsi con l’altro (e quindi conoscerlo) -dicendo con ciò l’aikido ai raggi x-, appare evidente che il problema non è riducibile a meri schemi didattici.
L’altro con cui l’aikidoista è separato e non armonizzato è, innanzitutto, proprio il “confratello” che segue un diverso sistema didattico. Un’intollerabile aporia per chi dice di praticare l’arte dell’armonia -e con chi, di grazia?-.
L’armonia col nemico, rimane un vagheggiamento, un feroce inganno ed autoinganno se dalle secche delle disquisizioni sulle forme e stili, utili si, ma in ambito circoscritto, noi non salpiamo verso il cuore di noi stessi, a conoscere emotivamente e non solo logicamente, la nostra paura, la nostra invidia, la nostra distruttività.
Per fare questo il miglior sistema didattico è paradossalmente il peggior ostacolo!
Per compiere l’opera al nero, come direbbe la Yourcenar, bisogna perdere la corazza, smettere di difendersi, smettere di proiettare su un metodo, magari migliore di un altro, la soluzione dei nostri stessi inghippi, che potenzialmente necessita di tutti i metodi……purchè se ne sappia anche fare a meno, vedendoli per quello che sono, cioè mezzi più o meno abili, di cui disfarsi nella loro letteralità, per ritrovarci!
Se non so fare a meno anche del mio punto di vista, l’incontro con l’altro è precluso, ma lo era già dalla preclusione ad incontrare veramente me stesso, che ero inconsapevole dei miei oscuri presupposti. Fare ciò per davvero, richiede un passaggio -sufficientemente lungo- nell’oscurità dell’abbandono di tutti i propri punti di vista e nell’inermità conseguenziale. In questa fase non ci si può difendere, occorre rimanere indifesi.
 Non si può andare oltre i propri assetti, sia di consapevolezza, sia socio-culturali, mantenendo un’attitudine difensiva; una concezione e una pratica convenzionale dell’aikido, può allora risultare persino di ostacolo, subdolamente.
Non si può andare oltre i propri assetti, sia di consapevolezza, sia socio-culturali, mantenendo un’attitudine difensiva; una concezione e una pratica convenzionale dell’aikido, può allora risultare persino di ostacolo, subdolamente.
Il concetto di nemico, che difficilmente si capovolge nel vagheggiamento di un happy end, appare e scompare sulla mia scena nella variabile di come lo tratto, di come sono in condizione di trattarlo, non prima di un’incredibile forgiatura.
E’ forse troppo?
Ahimè, non ci sono alternative, bisogna farsi coraggio. Non posso nuotare senza bagnarmi, né fare il samurai rimuovendo il dolore e la morte.
Proprio a questo mi riferivo più sopra, affermando di aver amato di più l’aikido, quando, malvolentieri, non avevo calcato il tatami.
Si dice che qualcuno abbia domandato ad Osensei cosa avrebbe fatto se fosse tornato a nascere e si dice altrettanto che la risposta sia stata: “ Come una foglia al vento”.
L’aikido è la totalità del procedimento alchemico di cui l’opera al nero è solo una fase, ma la forca caudina attraverso cui preventivamente passare, se l’obbiettivo è la pienezza e la purezza delle fasi successive.
Come tutti i fatti psichici, anche se di natura processuale, le fasi sono conseguenziali ed eternamente compresenti. Possiamo dopo la macerazione della nigredo, aver goduto della intensità emotiva della rubedo e della pienezza coscienziale dell’albedo.
Ma l’opera al nero si fa tutti i giorni.
Avv. Angelo Armano